
allenatore (7 anni): “allora, da dove vuoi iniziare?”
pubblico ministero (48 anni): “beh, che sia una cosa seria perchè se poi perdiamo la partita mi tocca dormire in carcere…”
allenatore: “perchè, se invece vincono i detenuti escono?”
Zappiamo la terra per sognare le stelle o viceversa?

allenatore (7 anni): “allora, da dove vuoi iniziare?”
pubblico ministero (48 anni): “beh, che sia una cosa seria perchè se poi perdiamo la partita mi tocca dormire in carcere…”
allenatore: “perchè, se invece vincono i detenuti escono?”
Il carcere dovrebbe avere una funzione riabilitativa per il condannato ma in realtà diventa l’università del crimine. Come mai succede questo?
Guarda, in proposito bisogna fare un po’ di chiarezza perché, sì, è vero che il carcere o – come dice la Costituzione – la pena deve tendere alla riabilitazione del condannato, però prima dobbiamo metterei d’accordo su che cos’è la pena. Intanto la pena serve soprattutto prima di essere applicata, non dopo. Quando viene applicata vuol dire che quella sanzione, quella minaccia di cui ho parlato poco fa ha fallito il suo scopo. Se la pena dell’ergastolo viene comminata a chi commette un omicidio, ha un senso nel momento in cui viene minacciata perché si spera che con quella minaccia l’omicidio non venga commesso. Nel momento in cui l’omicidio viene commesso lo stesso, la pena, sotto il profilo della prevenzione (che è quello più importante) si è rivelata inutile.
E tuttavia deve essere applicata… perché altrimenti se non venisse applicata fallirebbe come minaccia. Bisogna applicarla perché una volta che è stata minacciata, una conseguenza necessaria è l’applicazione della pena, soprattutto perché altrimenti nelle altre occasioni non funzionerà. Almeno si sa che se anche in quel momento non ha funzionato come minaccia, però viene applicata, quindi si spera che la prossima volta, anche evidentemente con riferimento ad altri soggetti, funzioni veramente.
Questa è la vera funzione della pena, la pena ha una funzione soprattutto nel momento in cui viene minacciata, non nel momento in cui viene applicata.
La nostra Costituzione, tuttavia, ha imposto al legislatore di far sì che una volta che questa pena venga applicata perché deve essere applicata, questa pena abbia questo carattere rieducativo. Evidentemente un carattere rieducativo lo dovrebbe avere già di per sé una pena, comunque venga applicata. Perché è chiaro che quella persona, avendo subito una pena, dovrebbe avere ulteriori remore a commettere un altro reato. Di fatto però avviene, soprattutto in riferimento a coloro che delinquono per la prima volta, che il contatto che il carcere provoca – naturalmente con altri che hanno commesso dei delitti – fa sì che si affilino, anzi, le capacità di delinquere di questa persona. Qual è la ragione? La ragione è che l’amministrazione carceraria in Italia è tenuta in una situazione assolutamente precaria, nel senso che lo Stato spende per la giustizia (e anche per l’amministrazione carceraria, che rientra nell’amministrazione della giustizia) appena lo 0,8 o 0,6 per cento del bilancio statale: molto meno di quanto non dedichi alla Rai, molto meno di quanto non dedichi ad altre attività. Cioè, una percentuale infinitesimale del proprio bilancio.
Lo Stato italiano non si è mai preso veramente carico dei problemi della giustizia. Il nostro, rispetto a quello di altri paesi, è uno dei bilanci più miserevoli con riferimento ai problemi della giustizia. Non voglio scandagliare le ragioni, dico però che è così.
È chiaro che, quando si può spendere così poco, le carceri possono restare in questa situazione precaria di affollamento e di poca possibilità lì dentro, addirittura, di far scuola o di fare attività sportive o di fare cultura o di fare opera di rieducazione, di riabilitazione. È chiaro che le carceri diventano soltanto un posto dove si è privati della libertà e in più si sta assieme agli altri delinquenti, e quindi non ci si redime affatto, ma si diventa più delinquenti. Ma non sicuramente per mal volontà dei direttori delle carceri o degli istituti di sorveglianza.
Quando io vado a interrogare i detenuti nel carcere di Marsala debbo chiedere quattro sedie, siccome normalmente quando si interroga un detenuto si è almeno in quattro persone: un giudice, un segretario, l’avvocato che difende l’imputato e l’imputato. [Ebbene, ndr] nel carcere di Marsala, che è sede di tribunale, non ci sono quattro sedie a disposizione del personale, e la sedia deve essere chiesta in prestito, o qualche sgabello preso nella cella di qualche detenuto, e il detenuto deve venire nella zona interrogatori con lo sgabello sottobraccio. Questa storia va avanti da tre anni. E tu mi parli di rieducazione dei carcerati? Ma lì bisognerebbe iniziare a rieducare gli sgabellieri, che dovrebbero pensare a procurarsi uno sgabello per fare almeno un interrogatorio in modo decente. Questa è la situazione, e una scarsa, anzi punta attenzione dello Stato a questi problemi, una scarsa o quasi punta destinazione di risorse finanziarie a questi problemi.
Paolo Borsellino, 26.1.1989
[incontro con i ragazzi di un liceo di Bassano del Grappa, dal min. 41.20 – trascrizione tratta da P. BORSELLINO, Cosa nostra spiegata ai ragazzi, PaperFirst, 2019]
Durante il nostro ultimo incontro al tavolo del gruppo, abbiamo commentato la giornata trascorsa con i nostri familiari nel teatro del carcere di Opera e la lettera di Vito Cosco, che di quella giornata è stata protagonista.
Della lettera hanno anche parlato alcuni giornali, provando a farne uno scoop. Di sicuro le nostre storie non hanno la stessa risonanza di quella di Vito, ma dietro ognuno di noi c’è una storia e, come come ha detto Vito quel giorno… “per fare quello che abbiamo fatto c’è voluto poco tempo e poco impegno, ce ne vuole invece molto per capire quello che facevamo“.
La detenzione utile è quella che ti fa prendere coscienza di te stesso, non quella che ti costringe a oziare sul letto, intanto che aspetti il fine pena. Le emozioni che abbiamo provato quel giorno sono collegate a come recuperare il rapporto con noi stessi e con i nostri famigliari.
Io spero che dall’altra parte ci sia qualcuno che osserva realmente il percorso che fa il detenuto. Non chiediamo perdono o di cancellare le nostre colpe, chiediamo che vengano osservate e riconosciute le attività che svolgiamo in carcere e valutati i risultati.
A volte la televisione e i giornali parlano superficialmente di quello che fanno i detenuti pur di vendere, ma queste non sono vere notizie, è solo speculazione. La vera notizia sarebbe entrare nel merito di quello che fa il Gruppo della Trasgressione. Il suo lavoro è quello di tirare fuori dalla persona quello che la persona ha già ma che non sa di avere.
Il problema è che l’arte della maieutica non è facile, mentre è invece molto più facile, eccitante e vendibile, parlare di mostri che non potranno mai essere perdonati. Ma dedicare attenzione alle cose eccitanti e vendibili è esattamente quello che facevamo noi all’epoca in cui passavamo il tempo ad assumere e vendere sostanze invece che a occuparci di sostanza.
La sensazione che ho provato quel giorno, dopo la lettura della lettera e il discorso di Vito, è stata straordinaria, ma allo stesso tempo ho capito quanto possa essere difficile far comprendere alla gente il cambiamento che avviene in chi ha riscoperto la propria coscienza. Ho sentito dire a uno dei familiari presenti quel giorno che, se non avesse vissuto di persona questa giornata, per lei Vito Cosco sarebbe dovuto morire in carcere perché solo questo meritava.
Quando si fanno questi incontri, i giudizi smettono di essere coltelli e si arricchiscono di empatia. Forse è proprio di questo che il mondo ha più bisogno… di ascoltare con attenzione le storie degli altri… quello che non abbiamo saputo fare noi quando non prestatavamo attenzione alle vite degli altri.
Marcello Portaro e Angelo Aparo

Marcello Portaro
Torna all’indice della sezione
Mi chiamo Marcello Cicconi e sono un componente del Gruppo della Trasgressione. Il cinque giugno noi detenuti abbiamo avuto la possibilità di stare con i nostri familiari prima in teatro e poi nell’area verde, dove abbiamo pranzato insieme. Questo incontro si ripete da qualche anno ed è ogni volta più coinvolgente, soprattutto perché in questo modo i nostri parenti vengono a conoscenza di parti della nostra vita che per timore o per vergogna abbiamo sempre nascosto.
Quel giorno si è parlato della presa di coscienza di un detenuto, Vito Cosco, che davanti alla moglie e ai due figli ha letto una lettera nella quale parlava del proprio reato e del proprio pentimento per il male fatto. Il figlio di 13 anni a un certo punto è scoppiato a piangere e tutti noi lo abbiamo seguito. L’esperienza è stata molto forte.
Inizialmente avevo ritenuto eccessivo parlare di queste cose e in modo così aperto davanti ai figli ma, confrontandomi poi col resto del gruppo, ho capito che quel giorno è stato restituito al figlio un padre. Sicuramente il figlio ha capito che non deve emulare il padre per quello che ha fatto, ma che oggi può rispettarlo per la forza che ha avuto nel parlare del proprio errore e nel gridare il suo desiderio di riscattarsi: la giornata è stata per me una freccia al centro del bersaglio e, per il gruppo, un altro passo della nostra rivoluzione.
Anche a me quel giorno è successo qualcosa di nuovo. Io ho sempre vissuto in guerra con me stesso, distruggendo me e chi mi stava accanto. Frequentando il Gruppo della Trasgressione, ho cominciato a prendere confidenza con le mie emozioni, arrivando in qualche modo anche a capire cosa mi ha spinto a stare sempre in guerra e a commettere reati.
Da quando sono in carcere io non ho mai parlato ai miei cari del mio cambiamento e soprattutto non ho parlato di come ero quando ero in libertà; non ho mai raccontato a mia madre o ai miei fratelli la reale vita che conducevo e ciò che la mia voglia di distruggere mi portava a fare.
Per qualche ragione avevo bisogno di distruggere la mia vita, forse perché speravo che la mia distruzione potesse diventare motivo di rimorso per chi ritenevo responsabile della mia vita scellerata, cioè i miei genitori. Ma in carcere ho cominciato a conoscermi meglio. Certo, bisogna lavorare molto per arrivare sentire il cambiamento; nel caso mio, devo ammettere che non sono stato io a cercarlo, ma è stato il cambiamento a trovare me, anche se oggi convivo meglio con la persona che sono.
Comunque, il giorno dell’evento il dott. Aparo mi ha invitato a dire la mia sul tema del giorno. Io non mi sono tirato indietro, ma mi sono messo a raccontare di me come se in sala non ci fossero stati anche i miei familiari. Ho detto quello che avevo sempre tenuto sotto silenzio, cioè che a mia volta ho contribuito a sporcare questo mondo e che mi piaceva fare quello che facevo.
Mia madre, non avendo mai sentito queste cose, ha cominciato a piangere. Lei ha sempre saputo solo una piccola parte della mia vita. Comunque, dopo avermi sentito e mentre io stavo camminando col dott. Aparo, mia madre si è avvicinata e con tono di rimprovero mi ha detto: “Perché a me queste cose non le hai mai dette?”
La risposta vera non la so neanch’io. Non volevo deluderla… mi vergognavo… Oggi invece, dopo alcuni anni di carcere e di Gruppo della Trasgressione, sento il bisogno di dirglielo. Perché oggi sento questo bisogno che prima non avevo? So per certo che il carcere può peggiorarti, distruggerti o cambiarti radicalmente. Ma perché?
Spero comunque che di eventi come quello del 5 giugno ce ne siano di più in futuro. Sono occasioni che ci permettono di avere con i nostri familiari e con noi stessi una relazione più vera.
Marcello Cicconi e Angelo Aparo
Torna all’indice della sezione

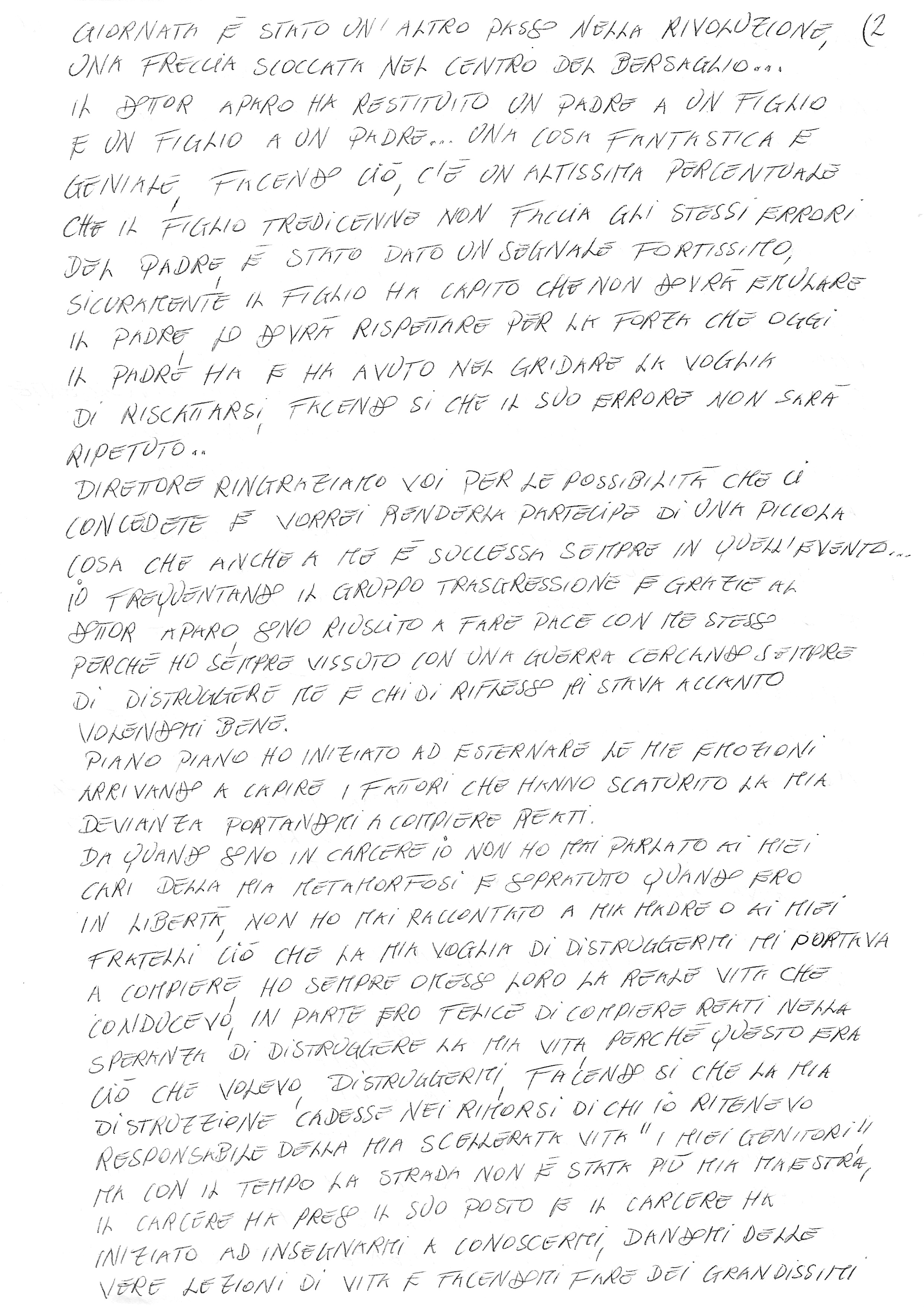
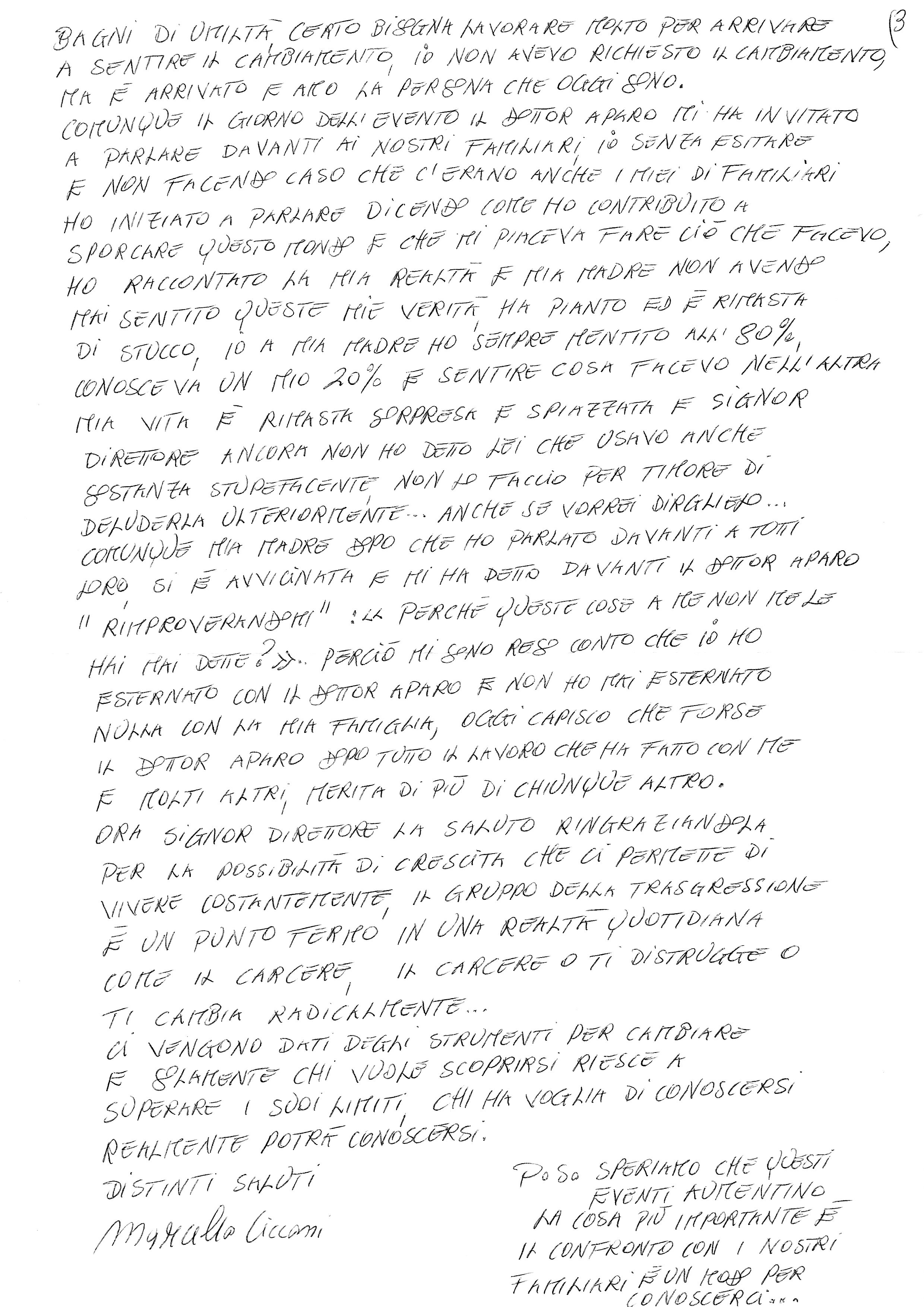
Marcello Cicconi
Il Gruppo della Trasgressione e Vito Cosco
Non possiamo fare a meno di chiederci come mai le prime aspirazioni di un bambino finiscano a volte per prendere la forma dei soldi che si ricavano da una rapina, della pace o della inconcludente eccitazione procurata dalle droghe. Se siamo sicuri che chi cerca l’oro e la droga sta sbagliando indirizzo, allora è doveroso chiedersi quali informazioni mancano a chi ha perso la strada. Se sbando mentre cerco me stesso, ho bisogno di qualcuno che non si limiti a punirmi ma che aggiunga un’indicazione utile per rintracciare l’indirizzo giusto (Angelo Aparo)
Vito Cosco, detenuto con la pena dell’ergastolo per l’omicidio di Lea Garofalo, si è presentato al gruppo mercoledì 29 maggio con uno scritto contenente le sue riflessioni sul reato commesso. Nel testo si percepisce l’evoluzione da uno stato precario di delinquenza sino alla individuazione della strada che conduce a una maggiore consapevolezza di sé.
Le sue parole hanno scosso ed emozionato tutto il gruppo e anche i famigliari dei detenuti, presenti il 5 giugno nel teatro di Milano Opera, giorno in cui il testo è stato letto e commentato pubblicamente. Gli stessi famigliari di Vito, compreso il figlio tredicenne, hanno manifestato dolore, gioia e orgoglio in merito alla trasformazione che un padre, marito e detenuto può avere. La giornata è stata piena di emozioni forti, pianti e sentimenti che hanno lasciato un segno tangibile nell’anima dei presenti.
Per via dello scalpore suscitato dallo scritto (non esattamente in sintonia con gli obiettivi e con lo stile del Gruppo della Trasgressione), il dott. Aparo ha deciso di raccogliere le considerazioni che componenti del gruppo ed esterni produrranno sul tema. In questo modo esse potranno divenire materia di riflessione e di dialettica e permettere a chi segue il nostro lavoro di farsi un’idea dell’operato del Gruppo.
Il progetto vuole provare a scuotere un’opinione pubblica ancora troppo ancorata al reato in sé e poco propensa all’idea che sia possibile l’evoluzione anche di chi ha commesso gravi crimini.
L’obiettivo primario è quello di comprendere che cosa la società si aspetta da persone che in seguito a un reato si trovano oggi con l’ergastolo o con lunghe pene da scontare; che cosa la Costituzione e le Istituzioni si aspettano da chi ha commesso errori in passato e quali strumenti offrono loro per farlo. Ci si propone, in definitiva, di cercare strade e alleanze utili a far sì che, a fronte della punizione, l’evoluzione del condannato e l’acquisizione di responsabilità verso l’altro non rimangano pura teoria o iniziativa lasciata esclusivamente a chi tale responsabilità ha dimostrato di aver dimenticato o di non avere mai avuto.
Valentina Marasco
Torna all’indice della sezione
Rashomon e il Kintsugi, ovvero… come passare dall’enunciazione di punti di vista diversi, tutti contenenti brandelli di verità e di menzogna (Rashomon, Kurosawa 1950) alla tecnica del Kintsugi, una cucitura che non nasconde le fratture, ma le ricorda con un filo d’oro che evidenzia le loro linee di sutura, la nostra coscienza del passato e la comune responsabilità del presente.
*****
Qualsiasi punto di vista, anche quando viene da persone non consapevolmente capziose, risponde al bisogno di ricostruire un quadro ragionevole della realtà, ma anche (e spesso soprattutto) a quello di dare una versione degli accadimenti compatibile con l’impostazione ideologica di un determinato momento storico. Vedi le diverse dichiarazioni che su “Lo Strappo” rilasciano i vari protagonisti del documentario, che a volte risultano contrastanti già all’interno dello stesso soggetto in quanto rappresentative di diverse epoche della stessa vita.
Il pensiero razionale, anche quando apparentemente libero, non è mai esente dal bisogno di garantire a noi stessi un ruolo sostenibile nella complessità delle cose. Tenendo conto di ciò, il ricercatore scientifico non si illude di essere sulle tracce della verità ultima, ma cerca una versione delle cose che permetta di formulare affermazioni utili a governare territori sempre più ampi e inclusivi della realtà.
In definitiva, la difficoltà di addomesticare la nostra complessità è quel che ci diverte e ci ricorda il nostro mestiere di uomini. Per questo cerchiamo persone che vogliano dar voce e nome agli interpreti principali dell’iniziativa: figure istituzionali, imprenditori, familiari di vittime della criminalità, ex criminali, studenti.
Il Kintsugi non punta alla verità e non vuole ignorare la difficoltà di tenere insieme gli uomini e le idee; cerca piuttosto di connettere i cocci di una passata unità, nella consapevolezza della loro comune origine e della loro e nostra precarietà.
Alcuni testi sul tema o ad esso collegati…
Fra i nostri attuali alleati:
“In piedi, da soli, non ce la si fa
per farcela, occorre un’Autorità”(Aparo dixit – 20 aprile 2018, ore 12.58)

[continua….]
Venerdì, 20 aprile 2018, ore 9:30-13:00
Aula Magna, Palazzo di Giustizia
Ingresso Via Freguglia, Milano
Ingresso libero. Non occorre prenotarsi. Si può entrare da Via Freguglia o dall’ingresso principale. Presentarsi entro le 9.
Il Convegno
Il Gruppo della Trasgressione è un laboratorio di ricerca sulla devianza, nato a San Vittore nel 1997 e dal 2008 attivo anche nelle carceri di Bollate e Opera. In linea con uno dei nostri principali filoni di riflessione, proponiamo quest’anno un convegno sulle funzioni dell’autorità. Il tema è fra quelli che portiamo avanti più assiduamente nelle carceri con i detenuti e con gli studenti universitari del gruppo e nelle scuole medie con gli adolescenti per i quali facciamo prevenzione al bullismo.