CORRIERE DELLA SERA, 24 dicembre 2018
La madre e l’assassino. Dialogo oltre i muri
di Paolo Foschini
Sembra facile? No, questa cosa non ci assomiglia neanche di lontano a una cosa facile. Chi ha subito un crimine, o ha avuto un familiare vittima di un crimine, lo sa molto bene. E lo sa anche chi un crimine lo ha commesso. Non è facile neanche pensarlo, di incontrarsi. Figurarsi farlo. E parlarsi. Eppure. Non è detto che le cose difficili siano impossibili. Forse a volte sono necessarie.
Per questo leggete, nel giorno di Natale, queste due lettere. Da una parte una madre che ha perso un figlio. Ucciso da un pirata della strada. Dall’altra un ergastolano. Che di figli di altre madri, in un’altra vita, ne aveva uccisi più d’uno. Non serve che sappiate i dettagli delle loro storie di “prima”.
Quel che invece dovete sapere è che il loro incontro non è stato casuale. Fa parte di un progetto, che di persone come loro ne coinvolge ormai parecchie. Autori di violenza, vittime di violenza. Si chiama Gruppo della Trasgressione, era nato 2i anni fa nel carcere milanese di San Vittore su iniziativa dello psicoterapeuta Angelo Aparo che lo guida tuttora, e il suo scopo era quello di “motivare i detenuti a interrogarsi sul divenire delle loro scelte”.
Oggi “è un laboratorio permanente di riflessione cui partecipano detenuti, studenti universitarie comuni cittadini”, non più solo a San Vittore ma anche nelle carceri di Opera e Bollate, oltre che in una sede esterna a Milano dove il Gruppo è ospite dell’associazione Libera. Gli obiettivi principali sono “il riconoscimento reciproco, la formazione degli studenti, l’evoluzione del condannato, Io sviluppo di progetti comuni”.
Come funziona? “Durante gli incontri, partendo dalle relazioni e dai vissuti dell’esperienza deviante, detenuti, studenti e comuni cittadini riflettono e producono testi su come si diventa criminali, sul modo confuso con cui il principio della giustizia è presente anche nel predatore, sul se e come si può rinunciare gradualmente all’eccitazione dell’abuso per il piacere della relazione, su quanto sia difficile stabilizzare l’equilibrio psico-sociale del neo-cittadino proveniente da un’adolescenza vissuta nella devianza”.
Non è un percorso lineare né semplice, appunto. Ci vanno anni e impegno. Ma qual è il risultato? “L’incrocio fra le diverse attività favorisce nel detenuto il piacere e l’esercizio della responsabilità nei confronti dei progetti comuni, un senso di appartenenza alla collettività allargata, acquisizione di funzioni sociali riconoscibili, la progressiva emancipazione dall’identità deviante”. Basterebbe assistere a uno dei tanti incontri cui i componenti del Gruppo partecipano nelle scuole di fronte agli studenti per la prevenzione rispetto al bullismo. “Studiare, progettare e lavorare con chi ha commesso reati – conclude Aparo – giova alla società più della distanza garantita dalle mura del carcere”.
Ecco di seguito le due lettere
Cara Elisabetta…
Grazie per non esserti fatta soffocare dal rancore
Cara Elisabetta, eccomi a te, con la responsabilità di chi ha offeso la vita, per cercare di restituirti parte della bellezza che tu quotidianamente ci regali. In questi giorni mi è stato detto se avessi il desiderio di scriverti una lettera. Non ho risposto subito perché pensavo tra me: ci chattiamo e sentiamo tutti i giorni, ci raccontiamo, ci ascoltiamo e ci sosteniamo per rispondere alle nostre fragilità e al tormento che regna nella solitudine dove tante volte ci rifugiamo… Che potrei dire di più a Elisabetta attraverso una lettera?”. Ma ho capito bene, da molto tempo, quanto è importante che la positività sia fatta conoscere. Anche solo per dire che è possibile. E allora ecco.
Tu e io ci conosciamo da circa due anni e da subito l’empatia ha fatto da timone per indirizzarci verso il riconoscimento reciproco del nostro dolore. Partecipi alle iniziative del Gruppo della Trasgressione, vieni a incontrarci, insieme organizziamo anche eventi. Quante volte ti osservo mentre sei avulsa dal contesto dove ci troviamo e proprio in quei momenti mi sento inadeguato; il mio pensiero si fossilizza nel baratro, dei sensi di colpa e mi fa sentire responsabile di questi tuoi attimi di smarrimento. Donna senza risparmio d’amore! Donna che non ti dai un attimo di tregua nel portare il bene dove ha prevalso sempre il male. Combatti come un guerriero e ti fermi solamente quando riesci ad accudire noi, me… La vita è un mistero e l’uomo può solo ipotizzare di conoscerne una parte. Proprio questo mistero, a mio avviso, ci può donare quella prossimità di cui parla e ha scritto tanto il nostro prof. Angelo Aparo.
Tu, come tutti gli esseri umani, spingi verso l’infinito ma, a differenza di tantissimi, un infinito ben definito: la fusione con Andrea, tuo figlio, che vive dentro di te e ti proietta a favore del bene. Un bene che riconosco, rispetto, di cui usufruisco e per il quale sono grato. Un bene che ti restituisce, ogni qualvolta scatta la magia, un battito del cuore di Andrea.
Ricordo, e spesso lo dici nelle tue testimonianze, quanta rabbia e rancore e voglia di vendetta albergavano nei tuoi stati d’animo. Non vivevi se non per cercare giustizia, contro chi commette reati e contro parte delle Istituzioni che non riconoscevano, fino a prima dell’inizio delle tue battaglie, l’omicidio di strada. Poi hai conosciuto il Progetto Sicomoro.
Progetto basato su incontri tra parenti di vittime o vittime e i carnefici, responsabili di reato. All’inizio è stata una lotta senza esclusione di colpi psicologici. Ma dopo i primi incontri, ascoltando e soprattutto toccando con mano la vulnerabilità e le fragilità di quegli autori di reato, ha prevalso in te la tua vera identità, la matrice ben cucita del tuo senso materno verso persone che hanno sbagliato ma dietro i cui sbagli vi è una infanzia abortita dal loro (mio) disconoscimento da parte di tutti, famiglia compresa. Hai percepito che dietro quelle maschere che hanno caratterizzato negativamente la nostra, vita ci sono uomini bisognosi di essere nutriti dal valore che ci permette di essere restituiti alla società. Credo che non ci possa essere iniziativa migliore di quella che stai portando avanti tu.
Ti sei fatta alleata con chi prima combattevi senza remore. Una grande responsabilità. Che richiede impegno ma soprattutto capacità di cambiamento rispetto a un pensiero iniziale. Un lavoro fatto da chi ha subito l’offesa più grande che una madre possa subire: la morte di un figlio, per guida spericolata, da parte di uno scellerato che di responsabilità era privo. Non sono giudizi che potrebbero uscire dal mio pensiero poiché, come sai, ho compiuto le stesse crudeltà a ripetizione. Ma oggi, sentendomi un cittadino, sento anche il dovere di testimoniare a favore di chi ha subito, compresi noi stessi. Sono fortunato. E orgoglioso che tu abbia sposato le idee e iniziative del nostro Gruppo della Trasgressione.
Mi permetto di estendere un grazie da parte di tutto il gruppo per dirti che sei un valore aggiunto e una ulteriore fonte di speranza soprattutto per chi, come te, ha subito atrocità ed è ancora soffocato dal rancore. Vorrei scriverti tante altre cose ma questa è una lettera aperta nella quale un podi intimità nascosta non guasta. Raccontarsi con gli altri è un bene, raccontarsi a quattrocchi è amore.
Ti lascio con una sorta di poesia che ho scritto in uno dei tanti miei momenti di smarrimento. Eccola.
“Due occhi tra, le canne di bambù ascoltano il silenzio della notte che accarezza i pensieri. Gocce che cadono, diamanti senza luce, frecce di dolore piantate nel cuore. Eco di passi severi, tra le mani un raggio di sole che illumina occhi anelanti a libertà. Un attimo, un bagliore nel buio. L’anima si nasconde, vuole l’oblio delle colpe, mentre il cuore intona il canto del perdono”.
Con immensa gratitudine.
Roberto Cannavò
Caro Roberto… sono una vittima,
ma non si può fermare il bene
Esco dal carcere quasi di corsa, esco dal carcere e ho bisogno di una boccata d’aria, di luce. Ho bisogno di riprendere i contatti con il mondo esterno che pare mancarmi da tantissimo tempo. Esco dal carcere e mi rendo conto di aver fretta e so che la strada che mi separa da casa mi parrà interminabile.
Il punto è che lì, in quella dimensione dagli spazi finiti, sbarrati, ovattati, mi sono sentita soffocare e dentro quelle mura che violentano la libertà nulla sembra esistere se non il presente e un pesante passato che ha segnato tutte quelle vite. Prima di uscire mi sono soffermata due minuti a chiacchierare con un agente. Non avevo mai visto corridoi sbarrati che portano alle celle. E la mia prima volta in carcere. Guardo a destra e poi a sinistra. Sbarre e volti. Sbarre e mani. E braccia lunghe che le oltrepassano quasi a volermi toccare. Sbarre e mani e occhi che mi cercano.
Ho voglia di scappare perché quella visione mi fa male e dentro me ho solo spazio per il dolore perenne che provo per la morte di mio figlio. Sento la mia corazza farsi di cartapesta e non riesco più a celarmi dietro la coltre di rancore e odio che mi ha avvolta per quattro interminabili anni. Sono una Vittima, io. Sono una mamma monca, spezzata, mutilata. Una donna entrata in carcere per urlare agli autori di reato il mio dolore e per nessun’altra ragione che puntare il dito. Da giudice. Da inquisitore. Sono arrabbiata, legittimamente arrabbiata. Sono Vittima per sempre.
Ma ora, nell’uscire da quel luogo di espiazione mi sento meno calata nel mio ruolo totalizzante. Ogni certezza si sgretola e provo una salvifica compassione per gli autori di reato. Compassione nell’accezione più nobile di questo termine troppo spesso frainteso. Provo compassione e non comprendo come un essere umano possa sopportare una vita dietro quelle sbarre.
Proprio io che dietro quelle sbarre ce li avrei mandati tutti, i delinquenti. E senza neanche un giusto processo. Senza dovere aspettare quei tre gradi di giudizio che mi parevano un’enorme perdita di tempo e un grande spreco di denaro pubblico. E invece ecco che, calata in questa dimensione inaspettata, nessuno, ma proprio nessuno, neanche il più spietato assassino mi provoca sentimenti negativi. Nuovamente tento di combattere con quella che ero e che non sarò mai più. E mi dico che non posso trovare giustificazioni a tanto male e che la clemenza non rientrava proprio, neanche un po’, nei miei progetti di mamma orfana. Arrogante e chiusa nella mia bolla che credevo impenetrabile, mi atteggiavo a giudice senza averne alcun titolo. Ma arretra ogni difesa e perdo questa ardua lotta contro la mia gabbia fatta di odio e rancore. Da allora li incontro sempre. Sono persone, sono esseri umani che hanno sentimenti, che provano vergogna, rimorso. Persone che chiedono una seconda possibilità. Racconto il mio vissuto e trovo occhi pieni di lacrime e trovo solidarietà. Siamo facce della stessa medaglia: il dolore. Quello subito, quello provocato. Quegli occhi, quelle storie entrano dentro di me ed agiscono come il ferro operatorio di un abile chirurgo. Entrano nella carne e la feriscono, la fanno sanguinare. Quel ferro arriva in profondità e va a cercare il male per sradicarlo. Brucia, ma cauterizza. Ora so. Ne ho le prove.
Il male si può sconfiggere, si può arginare, si può anche fermare. Ma il bene no. Una volta innescato, il bene dilaga e invade e pervade, inarrestabile e permeabile, travolge tutto ciò che c’è intorno.
Mi sento una donna migliore. Sento che possiamo fare un pezzo di strada insieme, senza fretta, curandoci le ferite con un sorriso o un abbraccio. Senza troppe parole, fusi nei nostri ruoli e nei nostri dolori. Fuori piove, ma noi abbiamo il sole dentro. Si chiama Ascolto, Accoglienza, Amicizia, Affetto, Amore. Per me si chiama anche Andrea.
Elisabetta Cipollone

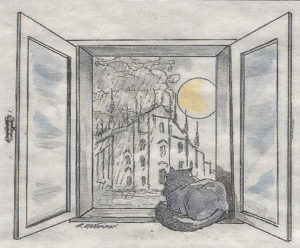 Saranno a Milano più gli alti o i bassi, i chiari o gli scuri? Dipende probabilmente anche da come si guarda, da quale prospettiva e, forse, con quale stato d’animo. C’è infatti chi trova imperdonabile qualcosa che un altro nemmeno nota. E c’è chi per gli aspetti positivi della nostra città proprio non riesce ad avere né occhio né orecchio: sogna Barcellona, Parigi, Berlino, Vienna, Londra e a Milano gli sembra di vivere in un incivile, arretrato borgo selvaggio.
Saranno a Milano più gli alti o i bassi, i chiari o gli scuri? Dipende probabilmente anche da come si guarda, da quale prospettiva e, forse, con quale stato d’animo. C’è infatti chi trova imperdonabile qualcosa che un altro nemmeno nota. E c’è chi per gli aspetti positivi della nostra città proprio non riesce ad avere né occhio né orecchio: sogna Barcellona, Parigi, Berlino, Vienna, Londra e a Milano gli sembra di vivere in un incivile, arretrato borgo selvaggio.
