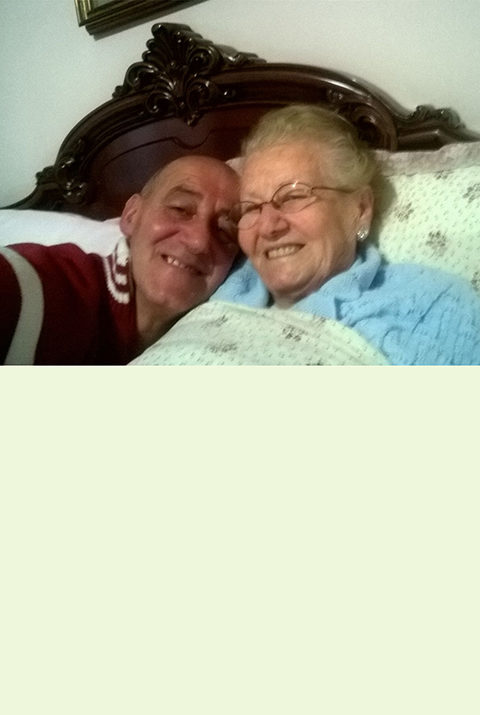Pedala, sennò cadi
Nicolas Aureli
Ci sono certe prime volte che non ti rimangono impresse nella memoria, mentre altre difficilmente se ne andranno via. Pochi ricordano la prima volta che hanno comprato un vasetto di marmellata, o la prima volta in cui sono saliti sopra ad un ponte; ma ci sono quelle prime volte che sono così importanti che diventano indimenticabili, un confine da cui si può decifrare con precisione un prima e un dopo (e non sto parlando esclusivamente di quelle prime volte in cui i vestiti sono sparpagliati sul pavimento). Spesso può avvenire un cambiamento così profondo che la persona dimentica completamente come fosse la vita prima di quel determinato evento, quale visione avesse del mondo attorno e un po’ di chi fosse. Voglio raccontarvi di due prime volte, così distanti nel tempo eppure così simili.
Ero un bimbetto di poco più di un metro (circa 80 centimetri fa), di poche parole e una capigliatura che allora non mi sembrava così imbarazzante (o forse ancora non sapevo cosa fosse l’imbarazzo). Come tutti i giorni di primavera gironzolavo in sella al mio biciclino nel solito parcheggio davanti a casa dei miei nonni. Questa volta però non stavo sfrecciando da una parte all’altra… ero fermo, saldamente ancorato al pavimento con tutti e due i piedi e le manine che iniziavano a sudare sul manubrio di plastica. Un osservatore poco attento avrebbe potuto non accorgersi della differenza dai giorni precedenti: lo stesso bambino, nello stesso parcheggio e con la stessa bicicletta.
Ma quella volta c’era qualcosa di meno, così piccolo eppure così importante. Era il primo giorno senza le mie preziose rotelle, il mio unico sostegno. Mi ricordo che nel pomeriggio mio nonno aveva violentato la mia piccola biciletta svitando con un cacciavite la mia sicurezza, lasciando il macabro trofeo sul bancone del garage. “Oggi è il giorno in cui diventi grande” la faceva facile lui, mica doveva trovarsi d’un tratto senza certezze, su una sella dove l’equilibrio non lo dovevi trovare in rotelle di plastica ma dentro di te!
Appena levavo un piede dal pavimento per metterlo sul pedale e la bicicletta iniziava pericolosamente a traballare, riappoggiavo immediatamente il piede a terra. Ero completamente bloccato, i miei timidi tentativi di partenza non sortivano l’effetto desiderato. Più ci provavo e più mi agitavo e più mi bloccavo. “Non devi aver paura, l’hai sempre fatto e sai come si fa!” Bravissima persona mio nonno ma come motivatore era davvero scarsino e banale. Però ho provato ad ascoltarlo. Una gamba, poi l’altra, la pressione sul pedale. I primi giri di ruota e il manubrio che tremava cambiando di continuo direzione. Il terreno che sembrava volesse a tutti i costi abbracciarmi. La gravità che non era mai stata così pesante. Ero instabile e insicuro, non sapevo a cosa appoggiarmi.
“Non ti fermare, se no cadi! Continua a pedalare!” non potevo abbandonarmi ma dovevo faticare e spingere verso il basso quei dannati pedali. Con sempre più convinzione, la ruota iniziava a girare più forte e il manubrio traballava molto meno. Aveva ragione il nonno nella sua banalità! Era davvero una cosa che avevo sempre fatto e che sapevo fare, solo che ora non avevo nulla che mi proteggesse. Et voilà, ho imparato ad andare in bicicletta. Non che non sia mai caduto, anzi, molto probabilmente non mi ricordo nemmeno un centesimo di tutte le volte che mi sono ritrovato sdraiato sull’asfalto (e chissà quante altre volte mi ricapiterà!) ma avevo iniziato ad andare senza rotelle ed ero diventato grande.
L’altra prima volta che vi voglio raccontare è successa a circa vent’anni di distanza dalla precedente. Era una mattina di inizio primavera, una di quelle in cui prima di uscire pensi per 10 minuti se sia il caso di mettersi la giacca invernale o qualcosa di più leggero (e puntualmente sbagli ritrovandoti a crepare di caldo o a lamentarti per il freddo). Via Pusiano 52, alla fine di un vicolo a senso unico c’è l’Istituto Pia Marta, un comprensorio di più edifici su un enorme parcheggio centrale. Le scuole si assomigliano tutte, come con gli ospedali riesci a riconoscerle a prima vista e in pochi secondi riaffiorano tutte le ansie di quando anche tu eri incatenato a quei banchi. L’appuntamento era alle 9:30 del mattino nel piazzale della scuola, ci siamo ritrovati cercando di sembrare più svegli di quanto in realtà non fossimo.
Ci siamo divisi in due squadre cercando di equilibrare gli anni di esperienza al gruppo. L’agitazione si poteva respirare, non c’eravamo preparati nulla ma questo è tipico del Gruppo della Trasgressione. Nell’aria galleggiava una domanda che nessuno ha avuto il coraggio di fare: “siamo davvero pronti?”. Stavamo per andare a fare il gruppo, una cosa che facciamo solo 5 volte alla settimana, in una scuola in cui eravamo già stati alcune volte, con ragazzi che avevamo già conosciuto; eppure era una cosa così diversa e nuova che nessuno si sentiva certo del risultato.
Quel giorno mancavano le preziosissime rotelle. Il fondatore e conduttore del gruppo, leader, psicoterapeuta e tante altre parole altisonanti, Juri Aparo oggi non ci sarebbe stato. Provare a descriverlo è molto più difficile del risolvere equazioni di secondo grado. C’è chi l’ha definito “bizzarro”, di sicuro non è la parola esatta ma è anche una delle prime che ti vengono in mente. Un concentrato di imprevedibilità che difficilmente si riesce a trovare in una persona sola: al gruppo non puoi MAI rilassarti, da un momento all’altro potresti ritrovarti a dover recitare una scena di Sisifo mentre pochi minuti prima si stava parlando della differenza tra le arachidi e le mandorle. Ma il prof è tanto imprevedibile quanto carismatico, qualsiasi membro del gruppo si farebbe senza battere ciglio da Opera al Duomo di Milano a piedi se te lo chiedesse. Con questo mix il prof riesce a gestire ogni situazione, qualsiasi imprevisto. Potrebbe benissimo parlare per 40 minuti di un tovagliolino del bar della stazione dei treni di Molfetta senza alcun problema. Spesso non capisci quale sia la direzione che stia prendendo, dove voglia arrivare o cosa capiterà tra pochi minuti ma sai che qualcosa uscirà fuori. La sua presenza è una sicurezza di riuscita, un paracadute che in qualsiasi situazione ti salverà.
Beh, oggi il prof non ci sarebbe stato, quindi si può ben capire di quanta responsabilità fosse caricato ogni componente del gruppo. Ognuno di noi doveva prendere in mano un remo per dare alla nostra zattera una direzione anche senza il suo “capitano”, per far capire che non siamo solo un mucchio di legnetti legati con un po’ di spago ma siamo un vero e proprio gruppo.
Suona la campanella, sono le 10 e dobbiamo entrare. Come sempre ci mettiamo in cerchio attorno a un tavolo su cui gettiamo un po’ di caramelle e qualche interrogativo sulla vita. Arrivano i ragazzi, si siedono tra di noi e dopo poche parole questa distinzione tra noi e loro cade. Questa è la magia del gruppo, qui sono tutti umani con le proprie colpe, i propri dubbi, le proprie idee e le proprie passioni. Puoi essere una persona che ha fatto piangere tante famiglie o puoi essere una che non schiaccerebbe nemmeno un moscerino che ti sta tormentando, ma a quel tavolo siamo tutti sullo stesso livello, siamo tutti uomini. Studenti, detenuti, volontari, tirocinanti, ex detenuti, tutti lì seduti su quelle scomode sedie a parlare di quella cosa così strana che è la vita. È la bellezza del gruppo.
Per conoscerci abbiamo messo sul tavolo la nostra storia, per aprire agli altri una piccola finestrella su ciò che siamo stati e ciò che siamo ora. Eravamo saliti sul sellino e stavamo iniziando a pedalare, come sempre i primi giri di ruota sono incerti. Il manubrio traballa, prima troppo a sinistra poi troppo a destra per raddrizzarsi. “Continua a pedalare! Non ti fermare, se no cadi!” E allora fai quello che hai sempre fatto: pedali!
I ragazzi sono stati fantastici (quei ragazzi segnalati dalle insegnanti perché più difficili ma che forse hanno sempre e solo avuto bisogno di poter parlare ed essere ascoltati), non abbiamo dovuto spiegare loro nulla, ognuno ha preso lo spazio che più gli si addiceva. Come le piante, alcune hanno bisogno di una luce intensa per poter fiorire; altre muoiono se le metti al sole mentre nella penombra riescono a sbocciare. Eravamo tutti interessati e partecipi a quelle storie così diverse dalla nostra eppure così vicine. In pochissimo tempo abbiamo visto i ragazzi aprirsi come spesso nemmeno dopo anni di terapia. Storie così toccanti che spesso avrei voluto gettare il mio cuore per terra per non sentire tutte quelle cose. Ma la cosa giusta da fare è l’esatto opposto, bisogna strappare un po’ di quella sofferenza e prenderla sulle proprie spalle per alleggerire chi la sta raccontando. Da soli non si riescono a combattere i propri demoni. Il gruppo è un valido alleato, ti fa capire che c’è qualcuno che ti ascolta, che ha già combattuto i propri demoni e che può allungarti una mano per aiutarti.
Quel giorno abbiamo dimostrato che il gruppo riesce ad andare anche senza le rotelle. Ognuno ha dovuto fare qualcosa in più del solito senza la protezione di una guida sicura. Ognuno di noi era una parte della bicicletta, le ruote che sembravano più gonfie del solito, il manubrio che assecondava meglio la strada, i freni che rallentavano senza inchiodare e la catena che girava come se gli avessero messo l’olio da pochi minuti. Ogni pezzo doveva sopperire alla mancanza di quelle rotelle su cui si poteva sempre contare. L’equilibrio ora dovevamo trovarlo dentro di noi e negli altri pezzi della bici. Avevamo interiorizzato le rotelle!
Lungi da me dire che ora il gruppo può fare a meno di un sostegno, ma di sicuro abbiamo dimostrato che la bicicletta sa correre anche da sola. Perché sono state proprio quelle rotelle ad averci insegnato a pedalare, quelle rotelle trasformano i sassi in menti che pensano. Abbiamo imparato che spesso le domande sono più importanti delle risposte, che spesso siamo troppo ancorati a risposte preconfezionate, che non sappiamo più dire quello che pensiamo se nessuno ce lo suggerisce.
Al gruppo non è importante il risultato ma il processo che l’ha portato, la fatica che si è fatta a mettersi in gioco, il lavorio delle teste che fumano a forza di pensare. Non siamo discepoli che ascoltano un messaggio ma persone che mettono in discussione ogni cosa di cui si parla senza per forza arrivare a una soluzione. Non vorrei abbandonarmi a banalità e frasi alla baci Perugina (cosa che per i miei gusti ho già fatto fin troppo nelle righe precedenti) ma le circostanze mi obbligano: al gruppo, come in bicicletta, a volte diventa davvero più importante il tragitto che la destinazione.
Per concludere questa relazione (che ormai si è trasformata in una vera e propria dichiarazione d’amore), voglio dire che il lavoro con la scuola Piamarta è stata una delle esperienze più arricchenti che abbia mai fatto e sarebbe una tragedia interrompere qui un percorso che sta già dando dei frutti succosissimi.