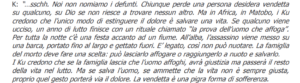Resoconto degli incontri
al Monumentale, alla Fabbrica del Vapore e al carcere di Opera
Il bel maggio si fa piovoso. E’ buffo, ogni volta che ci si incammina con i detenuti e gli studenti tra le sepolture del Monumentale il cielo è addensato di nuvole. E’ successo quando abbiamo girato le riprese finali di un percorso costruito in sette anni di collaborazione tra Liceo Artistico di Brera e Carcere di Opera, si è ripetuto nei due incontri di restituzione cittadina al Cimitero Monumentale e alla Fabbrica del Vapore di Milano. “Sposa bagnata sposa fortunata” verrebbe da dire e il matrimonio tra due mondi differenti come quello degli studenti e dei detenuti è stato felice per significato e relazioni tessute.
Il percorso autobiografico sul mito al Cimitero Monumentale con Antonio Tango (che ha appena finito di scontare una lunga pena) è stato accolto con vivo interesse dalle molte persone di differenti fasce d’età in tutti e due gli appuntamenti. Mentre arrancavamo tra le sepolture infangate dalla pioggia, nel tempo stretto che ci doveva poi portare alla Fabbrica del Vapore, seguendo Antonio veniva da cercare un senso al chi siamo e cosa ci facciamo al mondo. Con la poca scuola ritagliata in carcere, le cose apprese di straforo dalle guide ufficiali con curiosità insaziabile, ci ha condotto in un itinerario simbolico in cui ha illustrato i monumenti che hanno lasciato un segno in lui quando ha svolto servizio al Monumentale, scegliendo tra le sculture legate al mito i dettagli che gli hanno parlato: la Medusa, la spirale, il tradimento, Narciso, Amleto, la clessidra e il tempo fermo.
Antonio ha ricomposto i pezzi di una vita in cui è passato da un rapporto predatorio e rapace con la città d’adozione ad una dimensione estetica prima impensabile, dove può fermarsi a guardare e scoprire che la bellezza esiste: “Se oggi mi accorgo di una statua, lo faccio perché non sono pietrificato; ritenevo tutti responsabili del dolore che provavo. Solo comprendendolo, masticandolo, il dolore, sono riuscito ad elaborarlo. Oggi il dolore non mi pietrifica. Sotto la crosta, il rosmarino ha germogliato dentro di me, i dolori sono riemersi dalla pietrificazione del male e mi hanno permesso di riprendere a crescere perché la rabbia pietrifica anche la crescita, la voglia di curiosità. L’arte è anche quello che ci vede chi la guarda. La testa di Medusa la amo e la odio. Guardo quel grido che mi ha pietrificato la crescita. In alcune statue del Monumentale ho visto un Narciso con la mano sul mento che s’interroga sull’infinito, un ragazzo giovane che si specchia nell’acqua e entra nella sua morte. Cosa trovo io nella mia vita, in questa opera, in questo momento?”
La pietra e il soffio è il titolo del percorso al Monumentale. Un itinerario fatto di dettagli indicati dallo guardo di Antonio: una clessidra rovesciata, la sacchetta dei trenta denari sotto il tavolo dell’ultima cena, il viso di Medusa nel Monumento Fabé. Quest’opera mostra il peso del bronzo e l’immobilità della pietra in antitesi alla leggerezza e al brillio della ceramica smaltata in tenue azzurro dell’angelo di Fontana che, come la Nike di Samotracia, sopraelevata rispetto alla tomba, sembra liberarsi dal peso della materia per riprendere il volo, il respiro, il soffio di nuova vita.
Il lavoro di scavo intrapreso da Antonio e dagli altri detenuti del Gruppo della Trasgressione fa bene, prima però fa male: passare da quando non avverti il dolore dell’altro che annienti a quello in cui prendi coscienza di questo dolore, può indurti a disperazione. Il prezzo è alto, il vantaggio possibile.
Dopo il percorso al Monumentale eccoci arrivati alla Fabbrica del Vapore per la proiezione dei due filmati Eravamo cattivi, appunti sul gruppo della trasgressione, del regista Sandro Baldoni e Il teorema di Pitagora, esercizi su carcere e cittadinanza, docufilm che ripercorre tutta l’esperienza didattica. Il racconto dei due cortometraggi accosta universi distanti: un centro fatto di adolescenti liceali e una periferia al bordo dell’abitato che è città e non è più città: Opera, il carcere.
Sandro Baldoni, regista nastro d’argento che ha lavorato con noi in una lunga attività di volontariato, racconta dei due cortometraggi con la grazia di chi non si mette in mostra ma fa parlare le immagini, in stile sobrio con sprazzi di ironia. Ha il dono della sintesi e la pazienza dell’ascolto, anche se il treno non lo aspetta. Sandro è anche uno dei familiari delle vittime di una violenza cieca che priva delle persone amate.
Segue l’intervento di Paolo Setti Carraro, chirurgo nei paesi in guerra, vittima di mafia nell’attentato dove sua sorella Manuela ha perso la vita accanto a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le sue parole hanno la compostezza e la dignità che lo caratterizzano. Attualmente partecipa ad incontri settimanali in carcere nei percorsi di giustizia riparativa in cui familiari di vittime e rei tornano a parlarsi; uscire dai ruoli incomunicabili vittime e carnefici scollando l’aridità dell’anima è un modo per tornare a respirare e non incistarsi nel peso dell’odio e della vendetta.
Nella parte finale il suo intervento ha una nota nuova, un’incrinatura della voce quando riporta il racconto di Pasquale Trubia, che sconta delitti di mafia: uscito dal carcere dopo decenni per un frammento di tempo che gli consentisse di dare la sua testimonianza agli studenti, dal Palazzo di Giustizia (dove veniva richiesto il permesso di entrare a scuola) gli sono apparse all’improvviso le guglie del Duomo: come una rivelazione, una vertigine di luce dopo un secolo di assenza da se stesso. Ha tremato di emozione alla scoperta della bellezza, ha tremato di timidezza e responsabilità all’idea di parlare a ragazzi.
Questo sentimento è condiviso da Antonio, Rocco, Adriano, Roberto… non è più l’adrenalina di depredare la città ma la commozione per la sua luce, non è la durezza del non mostrare emozioni ma la pratica inedita della propria fragilità, violentemente espulsa dalla vita e da un carcere sovraffollato che può diventare scuola di altra devianza. A noi è toccato il privilegio di muoverci in esperienze pilota che cercano di attuare il dettato costituzionale dell’articolo 27 sulla funzione educativa della pena.
Seguendo il metodo Aparo chiamo le studentesse che con più intensa motivazione hanno partecipato al gemellaggio scuola-carcere a dire cosa resta loro delle cose fatte insieme. Le ragazze hanno nomi d’intonazione paradisiaca che fanno da ossimoro con quelli dei detenuti che vengono dalle periferie del Sud e che si chiamano Rocco, Antonio, Pasquale, Nuccio… Eccole, intimidite dal microfono: sono Chiara, Beatrice, Angelica, un’altra Angelica, e meno male che Celeste aveva un esame e non può esserci, che altrimenti ci piovevano addosso cascate di manna dal cielo e polvere di stelle! Qualcuna di loro è ancora in quarta liceo e aveva cominciato il percorso poco più che bambina, a quattordici anni, altre adesso sono studentesse universitarie. Niente di più distante da ergastolani e allora com’è che adesso Angelica abbraccia Nuccio e Pasquale stringe le mani a Chiara?
E’ che forse non sono più quel Pasquale assassino e quel Nuccio che la figlia non vuole vedere, è il Nuccio che ha letto una poesia in Siciliano dedicata proprio a quella figlia che lui andava a guardare di nascosto durante un permesso premio, mentre lei lavorava alla cassa del supermercato; è il Pasquale che ha cercato di morire quando è giunto alla coscienza del male fatto. Nell’autolesionismo pieno di tagli del detenuto si è rispecchiata Angelica che si tagliava a sua volta durante la pandemia. Eccole le ragazze dal profilo dritto e dagli occhi accesi mentre s’immaginano il Duomo attraverso gli occhi di Pasquale che lo sta raccontando dal vivo così come lo ha scoperto all’improvviso dal palazzo di Giustizia. Chiara sa la storia dell’arte e ci sarebbe venuta a piedi per essere presente a questo incontro, dalla sua Sicilia. Ed è venuta. Ha parole bellissime, le sentiamo in noi per la sua sensibilità. Come nel Gigante e la bambina di Ron, una delle due Angeliche ha ritrovato la parola accanto ad Antonio, è riemersa da una forma di mutismo a questo suo parlare di adesso, che vince una paralizzante timidezza.
Li ascolto mentre interagiscono, così diversi e così vicini, vengono in mente le note di uno spartito. Se Antonio Tango è stato protagonista di parte dei nostri filmati e della visita al Monumentale, i nostri incontri in realtà si chiamano Rocco, Pasquale, Roberto, Adriano, Pino, Angelica, Beatrice… si chiamano come tutti gli altri che abbiamo conosciuto e con cui ci siamo detti cose che contano. Insieme fanno una partitura corale, un concerto.
E non a caso con la musica terminano i nostri due incontri al Monumentale e alla Fabbrica del Vapore, con le parole poetiche di Fabrizio de André e i suoi canti degli ultimi, con il pescatore che non chiede il conto all’assassino, ma gli versa il vino e spezza il pane.
Proprio con questi testi, sempre nel filo della musica si apre, un mese dopo i nostri due appuntamenti al Monumentale e alla Fabbrica, la meritevole iniziativa I violini del mare contro l’indifferenza. L’interpretazione di Juri Aparo, calda e graffiante, risuona nel carcere di Opera, accompagnata dal violoncello del virtuoso violoncellista Issei Watanabe nel suo giovane viso ispirato. Li guardiamo, hanno entrambi gli occhi chiusi nella diversità delle loro caratteristiche, li ascoltiamo, viene anche a noi da chiudere gli occhi e da immaginare un mondo diverso, dove le cose possano cambiare come è stato per i reclusi che ci siedono vicini; possano cambiare le cose come crede don Luigi Ciotti, prete che costruisce ponti tra i diseredati. Quando parla, le sue parole sono pietre. C’è la sposa amata da Fabrizio, anch’essa una voce: Dori Ghezzi, che sarà testimonial in un tour per dire no all’esclusione e che ha apprezzato interpretazione e arrangiamenti della Trsg.band.
Nella liuteria del carcere di Opera il maestro liutaio Enrico Allorto fa realizzare ai detenuti i violini del mare, recuperando i legni dei naufragi, degli ammazzati dall’indifferenza dei privilegiati. Nel cimitero del Mediterraneo un papa venuto dalla fine del mondo ci ha ricordato cosa è pietas, cosa è ospitalità; di questa i greci fecero reciproca assicurazione sulla vita. Pegno di civiltà. Contava.
Ora c’è chi chiede agli scampati: ma lo sapevate che era pericoloso partire? Chi pensa al fastidio che dà trovare morti in mare, disturbano. Si è spezzata una corda. Non è così che ce lo immaginavamo, quando ci pareva ad un passo dal cambiarlo, quel mondo. Si è spezzata una corda; i liutai cercano di riannodarla. Siamo creature fragilissime, che si possono rompere da un momento all’altro. Non ce lo ricordiamo. Solo l’amore resta, nessun potere, nessuna ricchezza sopravvivono.
Ora, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese,
non ti mancherà una veste o cos’altro
è giusto ottenere arrivando da supplice sventurato. […]
Ma costui è un infelice, qui arrivato profugo,
che ora ha bisogno di cure: mendicanti e stranieri
sono mandati da Zeus. Il dono sia piccolo e caro.
(Odissea, VI, XI).
Giovanna Stanganello
Incontri con gli studenti