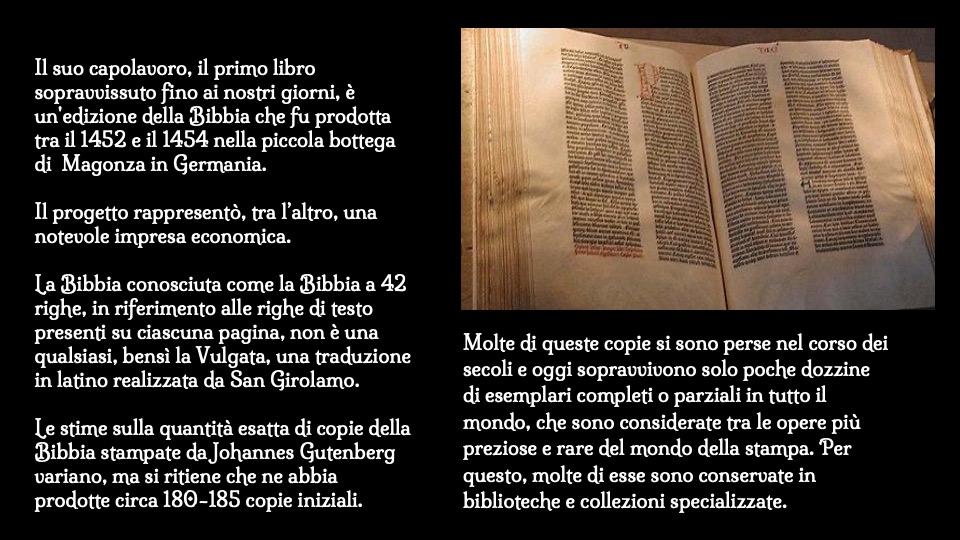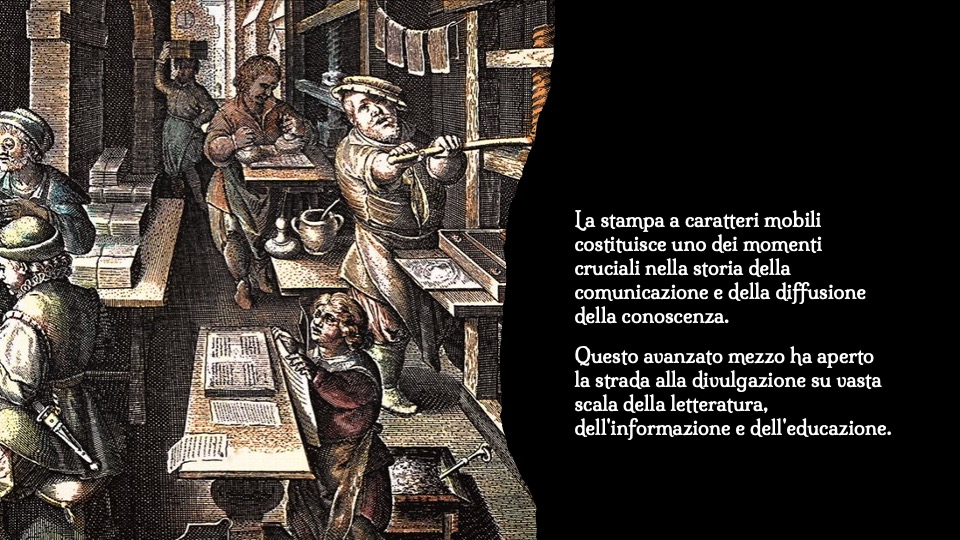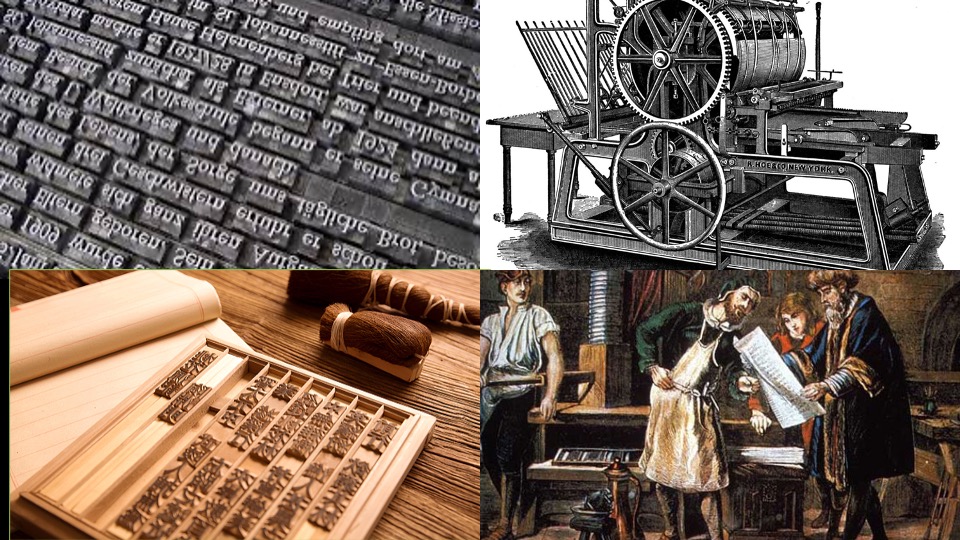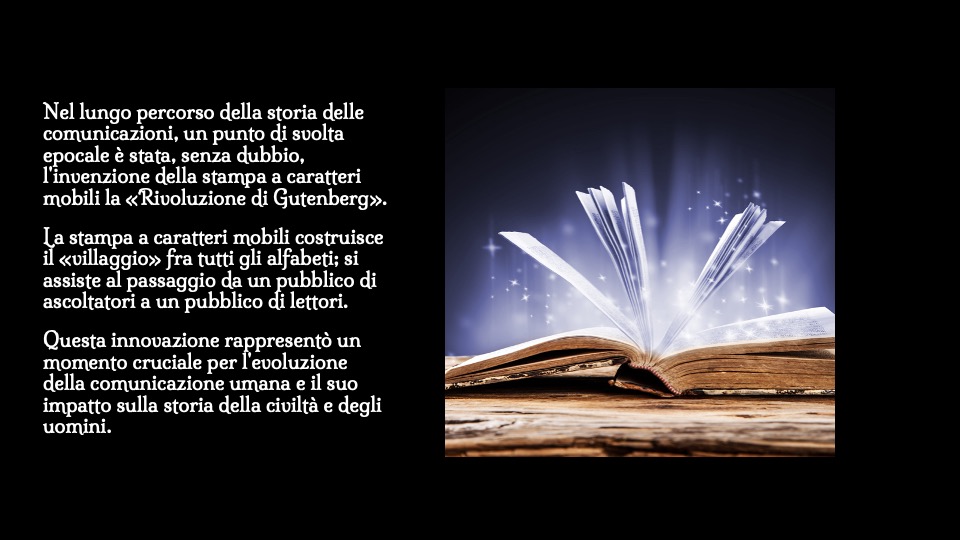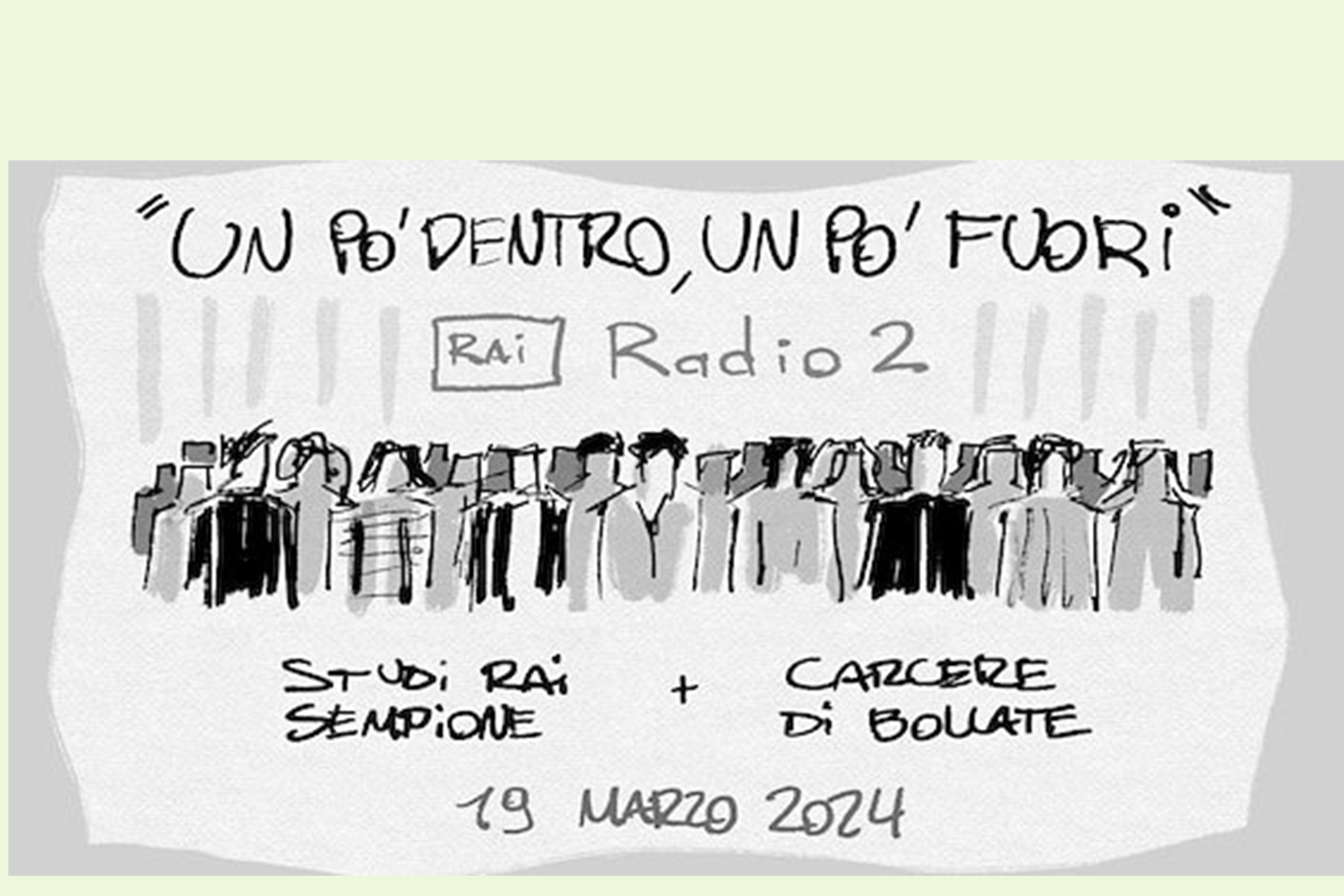Un credito, qualcosa che sentiamo ci sia stato tolto e pretendiamo ci sia ridato. Io. Tu. Stefano a cui è morto il fratello, poi il padre e che ha trovato rifugio nella droga. Marisa a cui la Sacra Corona unita ha portato via la figlia.
Ognuno di noi in questa stanza, in qualche momento, si sente creditore. Il debito è spesso d’amore, il debitore non sempre chiaro. A volte chiarissimo ma non escutibile e il credito insaldabile. In questi casi cosa si può fare? Chi lo deve pagare il mio credito?
Secondo Fabio, Giuseppe, Salvatore e gli altri detenuti questo credito per tutta la vita è stato visto come un qualcosa di non compensabile. Tutti loro odiano il padre che li ha abbandonati o che gli ha fatto mancare tutto quello che gli altri avevano. Hanno iniziato a delinquere perché questo credito qualcuno lo doveva pur pagare. Alla fine, lo hanno pagato loro. E lo stanno pagando tutt’ora dall’interno delle mura del carcere di Bollate.
Come dicevo anche Marisa ha un credito: sua figlia tossicodipendente, dopo una vita di abusi, ha tentato di collaborare con le istituzioni raccontando tutto ciò che aveva visto in sette anni. Quelle stesse istituzioni non sono riuscite a salvarla da chi la voleva far tacere. Marisa, davanti a quelli che il loro credito hanno provato a riscattarlo a danni di altri, ci racconta commossa come lei il suo credito continua a saldarlo giorno dopo giorno nelle carceri, a contatto con i detenuti che abbraccia e accoglie tutti. Così come Paolo, che non si dilunga sulla sua storia, già nota, ma, come Marisa, ci invita a riflettere su come è meglio viversi questo credito, in particolare su quanto quel credito che ognuno di noi crede di avere sia oggettivo e quanto invece sia solo una maschera che cela abusi dai quali ci si vuole deresponsabilizzare.
Un libro, I fratelli Karamazov, è al centro della nostra ricerca e forse ci può aiutare a rispondere ad alcune domande su questo credito, la mia ricerca personale, che si affianca alle ricerche di tutti gli altri presenti nell’Aula Dostoevskij, riguarda il ruolo della società in tutta questa faccenda del credito.
I quattro protagonisti del romanzo Dmitrij, Ivàn, Aleksej e Smerdjakov non sono in aula con noi mentre parliamo, ma è come se lo fossero, Salvatore a un certo punto dice infatti “A me nella vita è capitato di essere quattro fratelli in un solo uomo: come Dimitrij ero arrabbiato con mio padre, come Ivan non ho creduto, come Smerdjakov ho ucciso e come Aleksej alla fine mi sono rifugiato nella fede”. A questo punto il libro, diventa per noi subito un capolavoro, proprio perché lo stiamo leggendo insieme, all’interno del teatro di Bollate. Mi accorgo di questa fortuna quando torno a casa e racconto al tavolo della cena del primo incontro di questo progetto a cui sto partecipando e mia sorella mi dice “ma come fai a guardare in faccia una persona che ne ha uccisa un’altra”. Mi accorgo anche di quanto è difficile spiegare che dietro ad un fatto di reato c’è un uomo e che dall’azione deriva sicuramente una responsabilità penale, ma quell’uomo non è racchiudibile in quel fatto, c’è molto di più. Penso allora che probabilmente mia sorella se avesse letto il romanzo avrebbe, nel suo cuore, subito condannato Smerdjakov, uccisore materiale del padre, negandogli forse addirittura di parlare per spiegare, per lo meno, quale fosse il credito che sentiva di dover compensare in qualche modo. Le dico semplicemente che deve venire assolutamente a vedere con i suoi occhi, mi dice che ci sarà all’incontro di restituzione. Il 9 marzo è presente a Bollate all’incontro di restituzione e all’uscita mi dice solo “ho capito, grazie”.
A questo punto so di aver partecipato a qualcosa di importante e forse mi do anche una risposta alla domanda con cui ho iniziato questa ricerca: il ruolo della società in tutta questa faccenda del credito è innanzitutto riconoscere che un credito esiste. Se poi il credito viene riscosso in modo sbagliato e il creditore diventa debitore e si ritrova a dover giustamente rispondere delle proprie azioni, a volte parte della colpa è della stessa società che non è stata in grado di fornire gli strumenti o dei giusti modelli al creditore. Determinata la responsabilità per fatto di reato e nell’esecuzione della pena, il ruolo della società diventa quello di evitare lo stigma che ci impedisce di vedere e soprattutto riconoscere dietro il fatto più o meno grave un uomo, proprio come tutti noi. Questa è la missione più importante della società e ciò che consente alla nostra Costituzione di non restare lettera morta quando al suo articolo 27 comma 3 ci dice che le pene devono tendere alla “rieducazione”, meglio risocializzazione del condannato.
Maria Valenti