In questi ultimi giorni ho visto diversi film legati in qualche modo al tema del male nelle sue differenti manifestazioni. Sono film molto diversi tra di loro per tanti aspetti, legati anche alle diverse personalità e nazionalità dei registi e non solo. Ma se prescindiamo da ciò ed escludiamo, tra le altre cose, la diversità delle storie raccontate, i differenti contesti ambientali, culturali, politici, c’è un elemento centrale che è presente in tutti e che sottostà al tema del male e delle sue manifestazioni: l’Identità.
I film visti: L’odio, film francese di Mathieu Kassovitz – 1995; L’insulto, film libanese di Ziad Duoueri – 2018; Hannah Arendt, film tedesco di Margarethe von Trotta – 2014; Fa la cosa giusta di Spike Lee -1989, Elephant di Gus Van Sant – 2033, Bowling for Columbine documentario di Michael Moore – 2002, tutti e tre film americani.
In tutti questi film il problema identitario si pone sempre come centrale, è la molla che fa scattare l’odio, la violenza, il male. Anche quando non è esplicitamente evidenziato nel film, l’agire dei protagonisti ha come sottostante la questione identitaria.
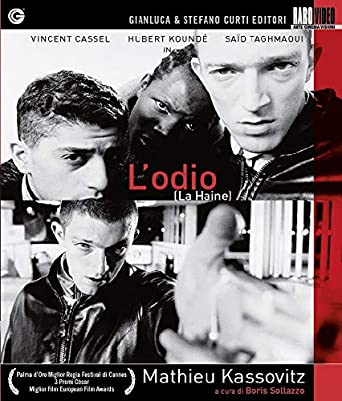
Nel film L’odio, la questione identitaria si pone nella continua disperata lotta che i tre ragazzi delle banlieu parigine, portano avanti con chi sta dall’altra parte, poliziotti e Parigi dei benestanti, che li condanna alla marginalità, all’invisibilità, all’indifferenza. Si comportano come fossero dei soldati armati dall’odio, in bilico tra la voglia di rispetto e di riconoscimento e la rassegnazione alla propria condizione. Tutto il film sembra il racconto di una inesorabile caduta, dove l’odio è uno degli impulsi che spinge a precipitare nel vuoto del male, che è il vuoto di ogni cosa annientata di senso in questo precipitare. Proprio come quel tizio che cade dal 50° piano in cui il problema non è la caduta, ma l’atterraggio. E l’atterraggio finale è drammatico, devastante.

Nel film libanese L’insulto, il forte sentimento identitario di appartenenza ad un popolo, è il motivo di fondo del conflitto tra i due protagonisti che, scatenato da un banale insulto, si estenderà poi come un incendio, alle opposte fazioni appartenenti a due popoli, segnati entrambi da violenze e atrocità, tanto subite, quanto inferte: i palestinesi da una parte, i libanesi dall’altra.

In Hannah Arendt, la questione identitaria si pone in due momenti diversi. Nel conflitto che vede la Arendt stessa accusata di essere una traditrice dell’identità del popolo ebraico, a causa delle sue conclusioni sul processo, pubblicate sulla rivista ‘New Yorker’. Poi nel processo che si svolge all’interno del film, dove la Arendt fa emergere la controversa teoria per cui esseri spesso banali (non persone) si trasformino in autentici agenti del male. Il gerarca nazista Eichmann, si dichiara semplice esecutore di ordini odiosi, non è altro che un ingranaggio della macchina del male nazista, deresponsabilizzato e non colpevole dei crimini a cui ha partecipato. In questa prospettiva egli ci mostra l’aspetto di banalità che può avere il male quando si manifesta nella sconcertante mediocrità dell’agire quotidiano del semplice funzionario. Ma certo è che sul piano della sua piena adesione e identificazione con il nazismo egli è sicuramente colpevole. Eichmann tutto può negare tranne che la sua identità era tutt’uno con il nazismo.
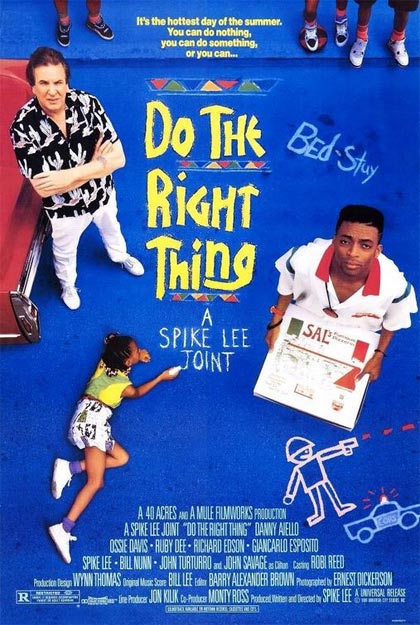
Il problema identitario si pone fortemente anche nel film di Spike Lee Fa la cosa giusta. In una comunità multietnica del quartiere di Brookling convivono afroamericani, italiani, messicani, coreani. Apparentemente sembrano andare d’accordo, in realtà una vera integrazione non c’è, anzi. Ognuno rimane chiuso nel proprio senso di appartenenza identitaria che provoca continui conflitti che esploderanno in una devastante violenza in cui sono tutti colpevoli, anche le forze dell’ordine.
 Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità.
Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità.
 Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?
Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?
Allora si può forse concepire che al bisogno di qualcosa nel cui significato (non importa quale) possa trovare risposta la domanda identitaria, questa risposta, alla fine, può anche essere il far saltare tutto in aria. Se poi, in un contesto già così nientificante, la forma identitaria socialmente promossa risponde all’imperativo “se non sei qualcuno, non sei niente, non esisti”, se è questo l’unico modo per essere riconosciuti e sentire di esistere, allora, non importa come, la risposta per orribile che sia, può ben tradursi in un atto umanamente inammissibile. Basta prendere dallo scaffale del market, piuttosto che da internet ciò che è lì, disponibile come qualsiasi altra cosa, e trasformare la banale e piatta quotidianità dell’esistere in un divertente gioco al bersaglio.
“Ma soprattutto ci dobbiamo divertire”, è una delle frasi che nel film i due ragazzi dicono prima della strage. Si divertiranno ad uccidere, come in un videogioco. Uccidere per divertimento è il loro modo di sentire? Sentire di essere vivi? Parafrasando crudamente una nota formula filosofica che esprime la certezza indubitabile che l’uomo ha di se stesso come esistente, si potrebbe forse dire: “uccido dunque sono”.
I due ragazzi si dissero di essere sicuri che dall’attentato sarebbe stato tratto un film. Due giorni prima della strage girarono un ultimo video nel quale si scusavano con le famiglie e si vantavano di come sarebbero stati ricordati con infamia dopo la loro impresa. “Sarà un giorno che sarà ricordato per sempre”.
In conclusione
Il bisogno identitario sembra essere la radice di un conflitto profondo che può trovare nel male, nelle sue differenti manifestazioni, una risposta, una funzione identitaria. Questo conflitto sembra esistere in partenza, sin dal momento in cui l’individuo, qualsiasi individuo, si pone l’imperativo di essere qualcosa, di riconoscersi, di affermare una propria identità.
Il bisogno di affermazione dell’identità è un atto conflittuale e divisivo di per sé? L’identità come sentimento di appartenenza a qualcosa, ad un clan, ad un gruppo sociale, alla famiglia, ad un popolo, nazione, idea, religione; ma anche alle proprie ferite, paure, desideri, è un atto di separazione da ciò che è altro da me?
Io appartengo alle banlieu, sono un soldato armato d’odio per chi sta dall’altra parte, e questo fa parte di quello che sono; io sono nazista, tu ebreo e ti uccido perché questa è la legge in cui mi riconosco; io appartengo a questo popolo e tu ad un altro, siamo in conflitto, siamo nemici. L’appartenenza è tutt’uno con l’avere un nemico da cui sentirsi separato, diverso, anche da quella parte di sé che non è ciò che dovrebbe o vorrebbe essere. E se poi la domanda non trova risposta dentro i confini socialmente accettati, la risposta può diventare devastante e trovare nel male la funzione che assolve a questo bisogno identitario, anche nelle forme più orribili.
Banalità e complessità del male, probabilmente questi due attributi sono indivisibili. Il male si presenta sempre sotto queste due forme. Ma non è il male ad essere banale o complesso. Il male di per sé è un concetto astratto. La banalità non è del male, il male che si fa non può essere mai banale. La banalità o mediocrità del male si innesta nel terreno della nostra quotidianità, quella che può essere vissuta e sentita come banale, mediocre, insignificante o semplicemente abitudinaria. Lo stesso vale per la complessità, che non appartiene al male in sé, ma a noi stessi, alle ragioni sottostanti le scelte che possono spingere a precipitare nel vuoto adrenalinico di un colpo di pistola.
Adriano Avanzini
Torna all’indice della sezione




 Se all’inizio del film si tratta di un banale incidente, che tutto sommato lascia loro la libertà di scegliere quale direzione prendere, alla fine diventa una questione di stato talmente grande che sfugge dalle mani dei protagonisti, i quali non possono nemmeno più scegliere di tirarsi indietro.
Se all’inizio del film si tratta di un banale incidente, che tutto sommato lascia loro la libertà di scegliere quale direzione prendere, alla fine diventa una questione di stato talmente grande che sfugge dalle mani dei protagonisti, i quali non possono nemmeno più scegliere di tirarsi indietro.

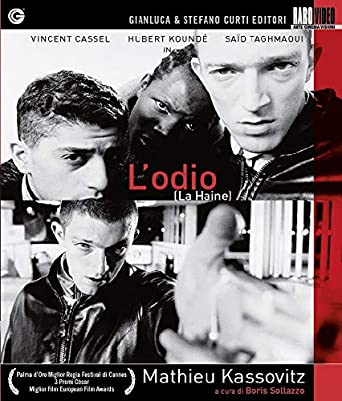

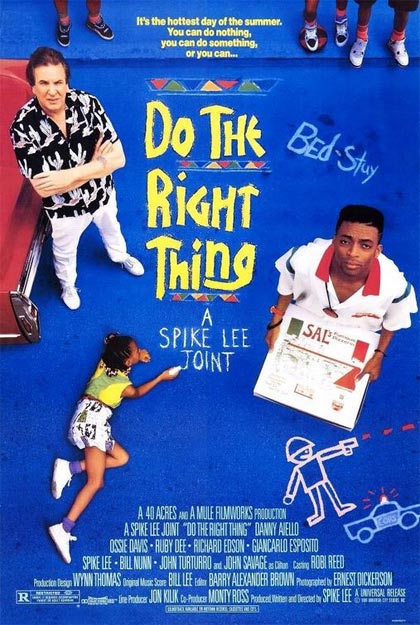
 Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità.
Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità. Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?
Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?


