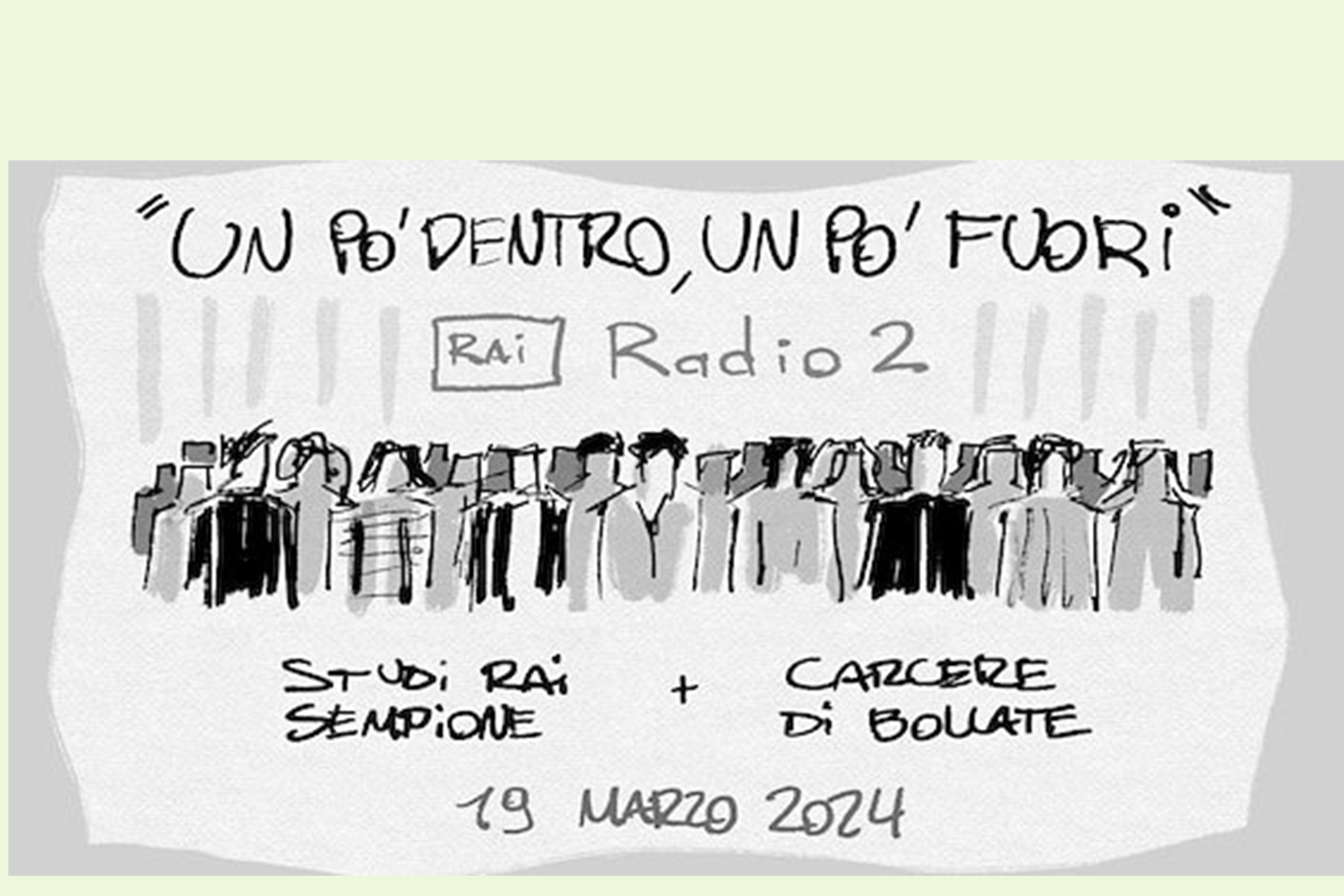Prima di condividere la mia testimonianza ho voluto aspettare il termine dell’ultimo incontro e ora, finalmente, penso di aver maturato un pensiero abbastanza completo e consapevole circa l’esperienza che stiamo svolgendo.
Conclusa una prima lettura del romanzo “I fratelli Karamazov” di Fëdor Dostoevskij, ho provato ad effettuare una seconda ri-lettura, ponendo uno “sguardo trasversale” tra i vari capitoli e ho notato che, paragrafo dopo paragrafo, l’autore indaga numerosissimi aspetti dell’animo umano: la complessità dei rapporti familiari, il contrastato rapporto con Dio, l’ascolto reciproco, i tradimenti, la sofferenza dei bambini, il perdono, la violenza – fisica e verbale- , la capacità di saper scegliere cosa è Bene e cosa è Male, l’attaccamento al denaro, le fragilità ed insicurezze dell’essere umano.
In particolare, mi hanno colpita i numerosissimi intrecci relazionali tra i vari personaggi, con le loro diversità, che contribuiscono a creare una storia dinamica ed appassionante.
Sicuramente, di importanza fondamentale per la narrazione è il rapporto tra il padre ed i quattro fratelli.
Il vecchio Fëdor si mostra da subito tanto superficiale nella gestione della vita privata quanto poco presente nella crescita dei suoi figli. Si pone in contrasto con il suo primogenito per questioni economiche e sentimentali (ha un grande debito da saldare ed entrambi sono innamorati della stessa donna dal fascino misterioso: l’usuraia Grušenka)
Dmitrij mostra in più occasioni una indole violenta e passionale. Cova dentro di sé un forte desiderio di riscatto e vendetta nei confronti del padre per le ingiustizie subite e per l’infanzia negata che, però, non sfoceranno in alcun gesto estremo. In lui batte un cuore buono, ma ancora disorientato ed impulsivo.
Il secondogenito Ivàn, al contrario, non condivide le scelte di vita del fratello e del padre e si dimostra una persona intelligente, colta e distaccata. In più occasioni affronta tematiche religiose, morali ed esistenziali, offrendo al lettore importanti spunti di riflessione.
Il terzogenito, Alëša, è il personaggio con cui è più facile entrare in sintonia: rappresenta la forma positiva dell’impetuosità karamazoviana ed è un importante punto di riferimento per gli altri personaggi: ragazzo devoto ed altruista, non volta mai le spalle a nessuno e la sua opinione, sincera e disinteressata, ha spesso un peso molto rilevante nelle scelte altrui.
Infine, abbiamo Smerdjakov, il quarto figlio, considerato come “illegittimo” e trattato alla stregua di un servo. La sua personalità presenta numerosi lati oscuri: instabilità, rancore e pensieri diabolici, che saranno la causa del suo tragico epilogo: l’omicidio del padre ed il suicidio.
Questo romanzo è sicuramente molto complesso ma altrettanto affascinante: nonostante risalga a più di cent’anni fa, rispecchia perfettamente la società odierna. È interessante notare come, all’interno di un nucleo familiare, le medesime origini dei componenti portino ad esiti molto diversi e quanto sia rilevante per la crescita di un figlio ricevere amore incondizionato ed attenzioni da parte dei propri genitori.
Un bambino ha il sacrosanto diritto di essere accudito con affetto, in un ambiente sereno e pacifico ma, qualora ciò non avvenga, da adulto dovrà trovare la forza di reagire e spezzare la catena negativa di soprusi e violenze a cui, suo malgrado, è stato sottoposto, per evitare di infliggere altro dolore.
Ascoltando le preziosissime testimonianze delle persone detenute, ci si rende conto di quanto ciò sia effettivamente reale: la maggior parte dei reati da loro commessi deriva proprio da un grandissimo vuoto affettivo e dal desiderio di gridare la loro esistenza.
All’interno del romanzo è dedicato ampio spazio anche alla tematica religiosa-esistenziale ed, in particolare, al travagliato rapporto Dio-Uomo: si alternano momenti di grande fede a momenti di totale negazione.
Il capitolo sicuramente più rappresentativo è “Il grande inquisitore”, da tutti considerato come il punto sommo dell’opera. Il racconto immaginario, narrato da Ivàn ad Alëša, è ambientato ai tempi dell’Inquisizione Spagnola e si svolge come una parabola il cui protagonista è Gesù in persona, che sceglie di ritornare sulla terra. Il Grande Inquisitore, rappresentante dell’autorità religiosa e politica, cattura Gesù appena arrivato a Siviglia e lo imprigiona. In un lungo monolgo, egli critica fortemente il messaggio di libertà e amore che Cristo vuole diffondere: è troppo complesso e la maggior parte delle persone vanno alla ricerca di sicurezza e controllo. La felicità terrena è sicuramente più realizzabile di quella eterna. Questo era il progetto dell’Inquisizione: portare una felicità che fosse a portata di tutti, poiché l’uomo non poteva ambire a nulla di più. Dostoevskij attraverso la voce del Grande Inquisitore esplora la complessità della natura umana, la nostra tendenza a cercare la sicurezza e l’ordine anche a costo della libertà.
Un altro episodio che merita una menzione è l’incontro al monastero tra i fratelli, il padre e lo Starec Zosima – la guida spirituale. Quest’ultimo tenta di convincerli a riconciliarsi, sostenendo che tutto il loro odio porterà soltanto ad altra violenza e che bisogna essere caritatevoli nei confronti del prossimo, proprio come insegna Dio.
Tra le sue frasi celebri, questa rappresenta al meglio la sua persona: “Ogni filo d’erba, ogni scarabeo, ogni formica, ogni piccola ape dorata conosce stupendamente il suo cammino e, pur non avendo l’intelligenza, testimonia il mistero divino, che si esprime in essi in ogni istante”.
Un terzo momento significativo e carico di tensione è il dialogo tra Ivàn ed il Diavolo. Ivàn era gravemente malato, con forti allucinazioni, e questo incontro avvenne proprio alla vigilia della febbre cerebrale con cui si presenta al processo del fratello. Il Diavolo viene immaginato come un signore dal bell’aspetto con capelli lunghi, brizzolati ed una folta barba.
Ivàn pronuncia frasi quali: “Sto delirando, non riuscirai a convincermi della tua esistenza. Tu non sei reale! Sei una malattia! Sei una menzogna!” E ancora: “Tu sei me, solo con un muso diverso. Dici esattamente quello che io penso”.
Ed il Diavolo risponde così: “E’ retrogrado credere in Dio ma io sono il Diavolo, in me si può credere. Quando inizi a non credere in me, inizi a credere che non sono un sogno. Io faccio soffrire, ma senza sofferenza nulla esisterebbe”.
Da questi spezzoni del dialogo si può facilmente intuire come vi sia una contrapposizione nella mente di Ivàn: da un lato la negazione, continuando a ripetere che il Diavolo sia solo una fantasia della sua mente malata, dall’altro lato la convinzione di non essere solo nella stanza, che culmina con il lancio di un bicchiere perché “Se non sei reale non ti posso colpire”.
In questi episodi notiamo come l’uomo cerchi di rinnegare l’esistenza di un’entità non terrena ma, allo stesso tempo, ne continua a parlare, come se l’idea della sua esistenza lo tranquillizzasse e, in un certo senso, ammettesse di averne bisogno.
Un ultimo momento, a mio avviso, significativo del romanzo è uno dei dialoghi conclusivi tra l’accusa e la difesa, all’interno dell’aula del tribunale, durante il processo a Dmitrij.
La prima afferma: “Se non lo condanniamo ne va a discapito di tutta la città..” La seconda afferma: “Se anche fosse colpevole, bisogna tenere in considerazione i motivi che lo hanno spinto a compiere tale gesto e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della vita,…”
Nella seconda affermazione noto un grande senso di umanità: la considerazione della persona nella sua totalità, non soltanto limitatamente al gesto che potrebbe aver commesso.
Nella prima affermazione, invece, riscontro tanta superficialità, come se fosse più importante trovare un capro espiatorio da sacrificare piuttosto che ricercare la verità. Sicuramente, condannare Dmitrij sarebbe stata la strada più facile e che avrebbe accontentato un maggior numero di persone.
Purtroppo, questo atteggiamento è ancora presente oggigiorno, non all’interno delle aule di tribunale ma tra le strade della città: assisto, sempre più spesso, a giudizi cattivi ed affrettati nei confronti di terze persone, dettati magari soltanto dal differente status sociale o dalla differente etnia di appartenenza.
In conclusione, la lettura del romanzo e, in generale, l’esperienza all’interno del carcere, mi stanno arricchendo moltissimo, dal punto di vista personale e professionale.
Ciò che più mi stanno insegnando è che bisogna avere un punto di vista ampio sulle cose e, soprattutto, non bisogna mai essere indifferenti nella vita – davanti ad una richiesta di aiuto, ad una persona sola o di fronte ad una situazione di violenza.
Nel nostro piccolo, il contributo di ciascuno di noi può essere immenso.
Elena Forzani
I Conflitti della famiglia Karamazov

 “Udite, fratelli miei: (il) frate(llo) che è qui dinanzi da voi, sì m’ha promesso, e fattomene fede, di far pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli promettete di dargli ogni dì le cose necessarie; ed io v’entro mallevadore per lui che ‘l patto della pace egli osserverà fermamente”.
“Udite, fratelli miei: (il) frate(llo) che è qui dinanzi da voi, sì m’ha promesso, e fattomene fede, di far pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli promettete di dargli ogni dì le cose necessarie; ed io v’entro mallevadore per lui che ‘l patto della pace egli osserverà fermamente”.